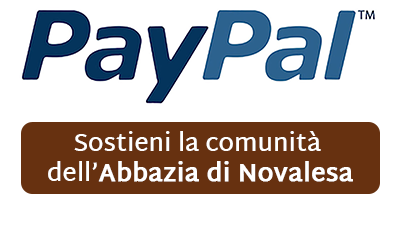Decidersi
III settimana T.O. –
Non c’è tempo da perdere e soprattutto non possiamo addossare al Signore Gesù la responsabilità della nostra paura e del nostro turbamento. Se il Signore dorme beatamente è perché il suo cuore non è scosso dalle onde del mare che significano gli assalti del male che cerca – proprio come l’acqua di un lago o mare in tempesta – di insinuarsi nella barca della vita snaturandola attraverso il turbamento. La paura trasforma la barca, da mezzo che permette di navigare placidamente, in relitto che trascina a fondo. La barca è sempre barca, come ognuno di noi è sempre se stesso, la differenza si crea a motivo di come lasciamo che le forze dell’esterno corrodano la nostra fede fino ad annientarla. La prima lettura ci dà una bellissima occasione per riflettere e per discernere il nostro cammino alla luce di quanti, in quel medesimo cammino, ci hanno preceduto, non certo con minori difficoltà di quelle che viviamo noi stessi.
La lunga e stupenda litania sulla fede dei nostri padri e delle nostre madri in cui sono ricapitolati e significati i cammini di tutti gli uomini e di tutte le donne di cui la storia non ha registrato i nomi, ma di cui serba indelebile memoria delle segrete ferite e delle gloriose, seppur invisibili piaghe, è come la risposta all’invito che il Signore sussurra all’orecchio dei suoi discepoli: <Passiamo all’altra riva> (Mc 4, 35). Da parte nostra rischiamo di sottovalutare il rischio inerente all’accoglienza di questo invito del Signore, pensando che il fatto di camminare attraverso le acque in sua compagnia ci esima da ogni pericolo… e invece: <ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca> (4, 37). Come i discepoli e ben prima di loro, lo stesso padre Abramo, <chiamato da Dio> (Eb 11, 8), forse si mise in marcia con la speranza di trovare ben presto una dimora per sé e una fecondità per la sua stirpe e, invece, quanto dovette attendere non solo quando <partì senza sapere dove andava>, ma per tutto l’intero percorso della sua vita: <egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso> (11, 10).
A nostra volta siamo chiamati ad imbarcarci sulla barca con il Signore Gesù e ciò significa sempre e comunque accettare di lasciarsi alle spalle la terraferma delle certezze per navigare nell’incerto mare della fede che è <fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede> (11, 1). La domanda che si pone è circa il motivo per cui il Signore Gesù permette un’esperienza come quella vissuta dai discepoli in mezzo al mare in tempesta tanto da indurli a implorarlo e quasi a rimproverarlo: <Maestro, non t’importa che siamo perduti?> (Mc 4, 38). L’esperienza dello smarrimento in mezzo alla tempesta conclude i racconti delle parabole e, forse, è un modo per il Signore di aiutare i suoi discepoli ad interpretare le parabole e ad applicarle alla loro vita. Ciò che in realtà può veramente uccidere quel seme che viene affidato alla terra del nostro cuore perché fruttifichi è proprio la paura di cui i discepoli sono costretti a prendere coscienza e che il Signore non esita a denunciare: <Perché avete paura? Non avete ancora fede?> (4, 40).
Due domande che ci scarnificano, soprattutto nel contesto della memoria dei padri e delle madri nella fede che furono <approvati da Dio> (Eb 11, 2). Con loro e come loro siamo chiamati attraversare il mare delle nostre inerzie per porci nel dinamismo dello Spirito.