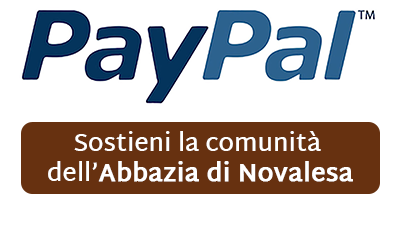Convertir… dehors
II Dimanche T.Q. –
Cette seconde grande étape de notre Carême est rythmée par un souvenir qui devient un avertissement, ou plus précisément une indication d’itinéraire : « Dieu conduisit Abraham dehors et lui dit : « Regarde le ciel… » ( Gn 15, 5 ). Ce n’est pas tellement différent de ce que fait le Seigneur Jésus avec ses disciples lorsqu’ « il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et grimpa sur la montagne pour prier » ( Lc 9, 28 ). Le rapprochement des deux textes nous aide à mieux comprendre le sens de l’un des éléments caractéristiques du chemin de Carême qui, avec le jeûne et l’aumône est vraiment la prière. Cela semble ne rien être d’autre que le consentement de notre humanité à sortir au-delà des frontières de notre propre confort pour s’ouvrir au « ciel » et grimper avec l’effort exigé sur « la montagne ». Que ce soit pour Abraham ou pour Jésus et ses disciples, il s’agit en réalité de consentir à une transfiguration – expression que Luc n’emploie pas – de notre regard pour y lire la réalité avec une nouvelle intelligence.
Le regard transfiguré est justement celui des amoureux ou d’une jeune mère face à son nouveau-né…il s’agit d’une capacité de voir plus loin, jusqu’à découvrir ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. Si cela est le côté merveilleux de l’amour, il ne faut jamais oublier qu’entrer dans cette manière de voir, reflet du regard du Très-haut qui nous transfigure continuellement, nécessite l’indispensable connexion d’une immolation Pour Abraham, dans la nuit du passage de Dieu comme Seigneur de sa vie, tout comme pour les disciples pendant la nuit de partage de la prière avec leur Maître, il y a un pas à faire qui exige la disponibilité d’immoler sa propre façon de penser et même d’avoir peur. La « terreur » ( Gn 15, 12 ) qui assaille Abraham n’est pas très différente de la « peur » ( Lc 9, 34 ) qui étreint le coeur des disciples face à l’étrange discours que Jésus entretient avec Moïse et Elie concernant « son exode, qu’il voulait accomplir vers Jérusalem » ( Lc 9, 31 ).
L’apôtre Paul connaît bien la difficulté d’entrer et de rester sur le chemin pascal jusqu’à implorer ses frères dans la foi « les larmes aux yeux » afin que personne n’imite ou se laisse fasciner par « les ennemis de la croix du Christ » ( Ph 3, 18 ). En ce deuxième dimanche de Carême, il nous est demandé de faire un pas supplémentaire « au dehors » pour monter avec Jésus vers « la montagne » qui préfigure déjà le Calvaire qui devient le tremplin indispensable pour expérimenter la joie d’avoir la « citoyenneté dans les cieux » ( 3, 20 ).