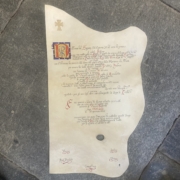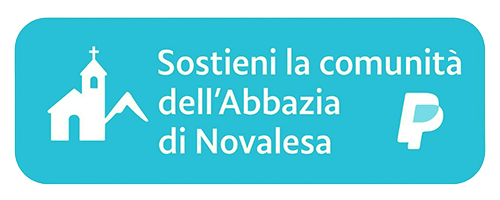Come lui
IV Settimana T.O. –
Le due letture ci mettono di fronte a un momento di consegne: <i giorni di Davide si erano avvicinati alla morte> (1Re 2, 1) e il re Davide sente il bisogno di fare delle <raccomandazioni al figlio Salomone>. Il Signore Gesù comincia ad inviare i Dodici e a mandarli <a due a due> (Mc 6, 7) proprio mentre la sua parola comincia a fare il suo duplice effetto sull’ambiente circostante. Da una parte infatti molti ne sono toccati e profondamente cambiati ma – subito dopo – veniamo a sapere che il cerchio della persecuzione e della eliminazione comincia a stringersi e, per questo, si fa memoria della morte del Battista. Davide sul letto di morte e il Signore Gesù in un momento di solitudine e di ritiro trasmettono in eredità la grazia e il segreto della loro relazione con Dio facendone un testamento ed una consegna. Le parole del re Davide sono assai semplici ma di grande forza: <Io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo> (1Re 2, 2). Sul letto di morte e nella coscienza delle luci e delle ombre della sua lunga e avventurosa vita, ancora una volta possiamo ammirare e ricevere in consegna insieme a Salomone il duplice segreto davidico. Da una parte l’umiltà, che fa sentire Davide sempre un uomo come <ogni uomo sulla terra> e, dall’altra, il dovere di essere fino in fondo fedele al proprio essere <forte>: sviluppare e far fruttare fino in fondo le proprie potenzialità di <uomo> secondo il cuore di Dio senza nessuna pigrizia e senza cedere a nessuna paura.
Parimenti il Signore Gesù, dando le consegne ai suoi discepoli e affidando a loro il compito di amplificare la sua parola e annunciare il suo vangelo, si mostra assai generoso e fiducioso: <dava loro il potere sugli spiriti impuri> (Mc 6, 7). Il Maestro non invia i suoi discepoli con “poteri limitati” ma con tutta la forza travolgente e trasformante del regno di Dio. E proprio perché si manifesti la potenza di Dio attraverso la loro parole e i loro gesti, il Signore chiede ai suoi discepoli di muoversi con grande agilità, libertà e rigore. Per questo <ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella borsa; ma di calzare solo i sandali, e di non portare due tuniche> (6, 7-8).
Nessun atteggiamento protettivo da parte del Signore nei confronti dei suoi discepoli né da parte di Davide verso Salomone, ma una preoccupazione iniziatica che, avendo fiducia nelle risorse di ciascuno, mette ognuno nella condizione di dare il meglio di sé pur nella condizione più svantaggiata e precaria. Davide chiede a Salomone di essere fedele alla <legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie> (1Re 2, 3) e il Signore Gesù chiede ai suoi discepoli di non temere nulla durante il loro cammino neppure il rifiuto: <andatevene e scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi> (6, 11). Questa forza e questa audacia, lasciata come eredità e consegnata come atteggiamento, permettono a Salomone di sedere <sul trono di Davide suo padre e il suo regno di consolidò molto> (1Re 2, 12). Questa forza dà ai discepoli, ormai divenuti apostoli, la capacità di predicare che <la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e lo guarivano> (Mc 6, 12-13). E noi di cosa mai abbiamo paura? Per ciascuno risuona il monito davidico ed evangelico: <Tu sii forte e mostrati uomo> (1Re 2, 2).