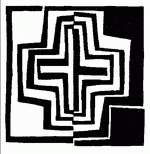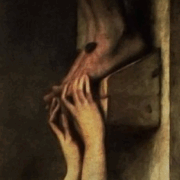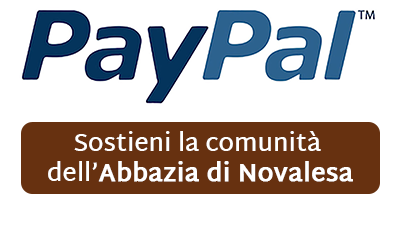Il tuo nome è Beneficio, alleluia!
Ottava di Pasqua –
Gli apostoli non si lasciano intimidire ed è proprio Simon Pietro, che non aveva resistito alle illazioni di una serva fino a rinnegare il suo Maestro, ad essere ora capace di mettere le cose in chiaro: <Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo…> (At 4, 8-9). Nel cuore degli apostoli è viva la memoria di tutto ciò che hanno vissuto con il Signore prima e dopo la sua Pasqua e ancora più pungente è il ricordo struggente della loro assenza durante la celebrazione esistenziale della Pasqua del Maestro. Ciò che resta è una sensazione profonda di essere stati beneficati, di essere stati rimessi sul sentiero della speranza e della vita anche quando tutto sembrava essere dominato dalla delusione e da un senso palpabile di morte della speranza: <ma quella notte non presero nulla> (Gv 21, 3). Eppure, nonostante tutto quello che è avvenuto, nel cuore dei discepoli sopravvive, per così dire, una docilità che permette comunque di ricominciare: <La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci> (21, 6). Uno dei messaggi più forti e più importanti del mistero della risurrezione, che stiamo celebrando in questi giorni di letizia pasquale, è la rinnovata speranza che tutto può sempre ricominciare.
Pietro lo ricorda con forza nel Sinedrio: <Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati> (At 4, 11-12). Le parole di Pietro non fanno che confermare un’esperienza che è quella mirabilmente vissuta dal discepolo amato. Questi è capace di riconoscere il Signore a distanza fino ad indicarlo agli altri discepoli. Quando si è imparato a conoscere il Signore, lo si può sempre riconoscere nonostante gli annebbiamenti del cuore e i turbamenti della storia: <E nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, perché sapevano bene che era il Signore> (Gv 21, 12). Questa certezza nasce proprio dal riconoscimento di questi gesti di cura e di amore che sono inconfondibili e fanno sentire il <beneficio> (At 4, 8) della presenza ritrovata del Signore il quale continuamente rinnova l’invito materno: <Venite a mangiare> (Gv 21, 12).
Ancora una volta si ricomincia dal quotidiano… il Signore Gesù raggiunge i suoi discepoli nel luogo a loro proprio e si accompagna al loro lavoro abituale. Anche dopo la risurrezione, il Signore non smette il suo grembiule di servitore tanto che colui che ha lavato i piedi ai suoi discepoli prima della Pasqua, ora fa arrostire il pesce e improvvisa del pane cotto sulla brace per riprendere così il filo dell’amore attraverso i gesti consueti dell’intimità. Per questo bisogna gettare la rete <dalla parte destra> (21, 6) ossia dalla parte giusta tenendo conto della presenza e della parola del Signore e non affidandosi al caso e a noi stessi che, spesso, accecati dalla paura rischiamo di sbagliare verso, per andare incontro alla corrente e al flusso della vita.