Convertire… in manna
IV Domenica T.Q. –
La Liturgia di questa domenica si apre con una solenne proclamazione da parte del Signore Dio al suo servo Giosuè nel momento in cui finalmente i piedi e i cuori degli Israeliti toccano finalmente la terra santa delle più sante promesse: <Oggi hi allontanato da voi l’infamia dell’Egitto> (Gs 5, 9). Il segno di un cammino compiuto e di una Pasqua interamente realizzata non sono come fuga dalla terra delle umiliazioni, ma anche come possibilità di pieno esercizio della propria libertà e creatività suona così: <E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti della terra di Canaan> (5, 12). Ciò vuol dire che da quel giorno il popolo dovette cominciare a lavorare la terra perché essa potesse dare la pienezza dei suoi frutti. L’esperienza del cammino nel deserto in cui il popolo riceve dal cielo il nutrimento di ogni giorno non è che la porta di ingresso in quella ordinarietà in cui ognuno è chiamato a ritornare al proprio lavoro, alla propria creatività, alla propria responsabilità.
Questo testo del libro di Giosuè scelto dalla Liturgia per introdurci alla lettura di una delle pagine più commoventi non solo delle Scritture ma di tutta la letteratura universale, ci aiuta ad intuire ciò che non è scritto e a osare una risposta alla collera del figlio maggiore della parabola. Si potrebbe glossare così e osare una conclusione che non è scritta: <E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato il vitello grasso e trascorso la notte a danzare, la festa cessò e ricominciò la vita ordinaria di lavoro e di condivisione della fatica>. In tal modo verrebbe a cadere l’scandalo adirato del figlio maggiore che si sente così ferito dalla benevolenza paterna che rischia di essere, ai suoi occhi, un segno di debolezza e quasi l’approvazione della condotta trasgressiva del figlio minore a detrimento della dedizione del maggiore: <Il figlio maggiore si trovava nei campi…> (Lc 15, 25). Anche il figlio minore dovrà riprendere la vita <nei campi>, ma non prima di aver gustato fino in fondo la <manna> di quella misericordia che, allontanando dalla sua vita e dal suo cuore, il minimo segno di <infamia> gli permetterà di riprendere la vita di sempre come una <creatura nuova>> (2Cor 5, 17).
Le parole del padre non sono una giustificazione della trasgressione, ma risuonano come l’accoglienza necessaria della realtà, unica e non moltiplicabile, di ciascuno dei suoi figli perché ognuno possa aprirsi a cose <nuove> senza essere prigioniero delle <cose vecchie>. Non bisogna però dimenticare che <vecchie> possono diventare persino le cose più buone e più sante se non sono continuamente rinnovate e rinvigorite nella giovinezza di un amore continuamente riconquistato e ritrovato. Così veniamo a scoprire che il più giovane della famiglia è proprio il padre il quale <gli corse incontro, gli si getto al collo e lo baciò> (Lc 15, 20). Come ricorda in uno scritto ormai classico uno degli autori più rilevanti del nostro tempo: <Quando guardo al mio essere perduto con gli occhi di Dio e scopro la gioia di Dio a causa del mio ritorno a casa, allora la mia vita può diventare meno angosciata e più fiduciosa>1.
1. H. NOUWEN, Le retour de l’enfant prodigue, Albin Michel, Paris 2008, p. 169.


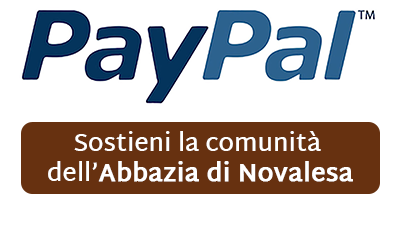


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!