Convertire… il diavolo
Settimana Santa –
Il triduo pasquale comincia, attraverso la lezione del Vangelo che ne segna le coordinate fondamentali, con due note apparentemente così contrastanti da sembrare inconciliabili. La prima suona così: <Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta l’ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine> (Gv 13, 1). A questo sfondo, dominato da un amore la cui immensità pare travolgere la storia, sembra che l’evangelista Giovanni abbia bisogno subito di dare una pennellata di scuro per farcene percepire tutta la profondità: <Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo…> (13, 2). Il gesto della lavanda dei piedi e quello del dono di un pezzo di pane e di un sorso di vino diventano così il modo con cui Gesù dichiara guerra al Maligno e alla sua logica di tradimento dell’amore. Una guerra dichiarata senza smettere di amare <fino alla fine> perfino e, prima di tutto, quel discepolo che lo consegna illudendosi di diventare così protagonista della storia e placando così il suo complesso di inesistenza a motivo della sua reale inconsistenza. Il modo di reagire del Signore a ciò che <il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda> è un di più di amore, un eccesso assoluto di amore che si esprime nel gesto di <lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarlo con l’asciugamano di cui si era cinto> (13, 5).
Vale per il gesto del lavare i piedi ciò che Paolo riferisce all’altro gesto eucaristico dello spezzare il pane e versare il vino: <Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga> (1Cor 11, 26). Possiamo applicare questa parola alla nostra vita quotidiana dicendo che <ogni volta> che sentiamo nel nostro cuore la morsa della tentazione che ci spinge a chiuderci all’amore, l’unica via è quella di aprirci ad un amore ancora più grande. Infatti, solo l’eccesso e l’esagerazione possono arginare l’opera del <diavolo> che lavora sempre nella linea del risparmio (non si poteva vendere per trecento denari) per arrivare a far trionfare la morte delle relazioni più belle e più significative. Simon Pietro lo intuirà cogliendo nella reazione del Maestro la posta in gioco di un passaggio fondamentale: <Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!> (Gv 13, 9). Il salmista ci aiuta a non dimenticare, perché la dimenticanza rischia sempre di essere l’inizio di un’insensibilità e per questo si interroga: <Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto?> (Sal 115, 3).
Potremmo entrare nella celebrazione dei santi misteri cercando di fare l’elenco dei benefici che abbiamo ricevuto nella nostra vita. Solo questa memoria ci potrà rendere immuni dalla tentazione del <diavolo> di cedere all’oblio e concentrarci per questo sulle nostre paure e sui nostri bisogni più immediati e passeggeri. La prescrizione rituale dell’Esodo assumerebbe così un valore assai particolare: <Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno> (Es 12, 5). L’agnello è Cristo, l’agnello dobbiamo essere noi resistendo ad ogni tentazione di trasformarci in lupi. L’Esodo continua con le sue note rituali che sono, in realtà, orientamenti esistenziali: <Ecco in quale modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore!> (Es 12, 12). Celebriamo la Pasqua per imparare l’arte di vivere che è sempre l’arte di amare, così antica e così magnificamente nuova perché richiede di ricominciare ogni momento: <Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi> (Gv 13, 15). Tutto ciò è pane per il cammino e vino per non perdere il ritmo e l’ebbrezza della marcia.


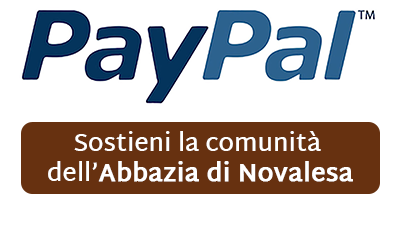


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!